di Petra Crociati
 La notizia letta su un quotidiano o ascoltata distrattamente in tv di una donna che, spesso dopo anni, trova il coraggio e la forza per denunciare il suo aggressore, porta quasi sempre a pensare che i maltrattamenti e le violenze subite da questa persona terminino il giorno in cui varca la porta di un ufficio delle forze dell’ordine. La denuncia di una violenza subita, come quella dell’anziana 80enne di Budrio vittima da 50 anni dei maltrattamenti e della violenza del “marito padrone”, per la maggior parte delle persone costituirebbe infatti la fine alla violenza stessa. Ma non è così.
La notizia letta su un quotidiano o ascoltata distrattamente in tv di una donna che, spesso dopo anni, trova il coraggio e la forza per denunciare il suo aggressore, porta quasi sempre a pensare che i maltrattamenti e le violenze subite da questa persona terminino il giorno in cui varca la porta di un ufficio delle forze dell’ordine. La denuncia di una violenza subita, come quella dell’anziana 80enne di Budrio vittima da 50 anni dei maltrattamenti e della violenza del “marito padrone”, per la maggior parte delle persone costituirebbe infatti la fine alla violenza stessa. Ma non è così.
Paradossalmente, per molte delle donne che decidono di procedere penalmente contro il loro aggressore, il periodo più rischioso della loro vita inizia proprio con tale decisione. Anche se la denuncia rimane il miglior strumento per la protezione giuridica delle donne, e l’aumento dei numeri è un fattore positivo da incentivare con una corretta informazione per riconoscere la violenza sin dai primi sintomi, rimane ancora difficoltoso garantire loro un adeguato supporto sociale, giuridico ed economico nella fase immediatamente successiva. Il rischio per la donna, allora, è duplice: sia che essa si trovi sola durante un procedimento di tipo penale in cui deve spesso fronteggiare umiliazioni e situazioni mortificanti da parte della comunità di appartenenza, che la rendono vulnerabile e contribuiscono alla sua vittimizzazione e colpevolizzazione; sia che, attraverso minacce, pressioni ed episodi di stalking, l’aggressore faccia leva sul lato emotivo, spingendo la donna – spesso dipendente economicamente dall’uomo in questione – a ritirare la denuncia e tornare in famiglia.
La recente approvazione del decreto legge che prevede, tra le norme in materia di sicurezza, anche alcune previsioni legate alla violenza di genere e al femminicidio, ha ricevuto molte critiche perché rinforza, per esempio, alcuni aspetti repressivi del contrasto alla violenza di genere, come lo strumento dell’ammonimento, l’irrevocabilità della querela o la procedibilità d’ufficio. Di contro, però, non prevede sufficienti stanziamenti alla fase preventiva, legata alla necessità di fornire un’adeguata formazione oltre alle vittime di violenza, anche alle forze sociali dove esse si trovano ad interagire: servizi sociali, forze dell’ordine, ospedali, scuole, chiese. Le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza, per esempio, sono ancora una percentuale bassissima secondo le stime ufficiali dell’Istat (2006). Così come ancora troppi sono i pubblici ufficiali, che pur rappresentando lo Stato, tendono a sminuire lo strumento della denuncia, non approfondendo i trascorsi di violenza della vittima e considerando, al contrario, il caso in esame come eccezione, restringendo così gli episodi punibili e negando il fenomeno della violenza contro le donne come fenomeno di massa.
Questi fattori possono aumentare la sfiducia nell’efficacia di un aiuto esterno che isola ancora di più la donna, soprattutto se non è indipendente economicamente e non trova dunque una possibile alternativa alla sua condizione, aggravandone così la condizione e la stessa incolumità. Qualora la donna non abbia la possibilità di allontanarsi dal nucleo familiare di origine, denunciante e denunciato possono addirittura continuare a vivere nella stessa casa. Per questo, appena viene sporta una denuncia per violenze fisiche o sessuali, diventa cruciale l’intervento tempestivo di servizi e istituzioni incaricati di garantire un reale supporto in termini psicologici, sociali ed economici.
La mancanza di finanziamenti sufficienti per una programmazione di lungo periodo e per una progettualità efficace nella fase di protezione delle donne in seguito alla loro denuncia, però, è l’altro grande problema: i centri antiviolenza lavorano costantemente in emergenza, rischiando la chiusura e non riescono a fornire, per esempio, un rifugio temporaneo a tutte le donne che vogliono uscire da un vissuto di violenza. Alcuni centri, per esempio, sono totalmente sprovvisti di posti letto per le donne. Alcune regioni italiane – fortunatamente l’Emilia Romagna è tra le più virtuose – non possono fornire nessun aiuto materiale alle donne vittime di violenza. Il Consiglio d’Europa raccomanderebbe a questo proposito un centro anti violenza ogni 10.000 persone e un centro d’accoglienza ogni 50.000 abitanti: in Italia dovrebbero esserci dunque 5700 posti letto, ma ce ne sono solo 500.
Petra Crociati


 E vissero per sempre felici e contenti. Finivano sempre così le favole che mi raccontavano da bambino. E io rimanevo in bilico: da un lato la felicità che era andato tutto nel migliore dei modi e dall’altro la tristezza che tutto era ormai finito. E così mi capita anche oggi. Se la vita è un grande libro ...
E vissero per sempre felici e contenti. Finivano sempre così le favole che mi raccontavano da bambino. E io rimanevo in bilico: da un lato la felicità che era andato tutto nel migliore dei modi e dall’altro la tristezza che tutto era ormai finito. E così mi capita anche oggi. Se la vita è un grande libro ... 
 Non mi era mai capitato di visitare una mostra di opere astratte. E' successo, per la prima volta, spinto dalla curiosità, per quella dell'artista Massimo Arrighi, nostro concittadino. ...
Non mi era mai capitato di visitare una mostra di opere astratte. E' successo, per la prima volta, spinto dalla curiosità, per quella dell'artista Massimo Arrighi, nostro concittadino. ... 
 Vi invio questa lettera per fare alcune riflessioni sul problema del "rusco".
Premetto che sono completamente a favore della raccolta differenziata e della possibilità del recupero reale dei nostri scarti, devo però dire che ho alcune perplessità sulla raccolta differenziata come sta avvenendo ora. ...
Vi invio questa lettera per fare alcune riflessioni sul problema del "rusco".
Premetto che sono completamente a favore della raccolta differenziata e della possibilità del recupero reale dei nostri scarti, devo però dire che ho alcune perplessità sulla raccolta differenziata come sta avvenendo ora. ... 
 Recentemente la comunità di Budrio e i suoi genitori sono stati sconvolti dal tentato adescamento subito da un bambino di 10 anni avvicinato in macchina da un uomo, mentre si recava da solo a piedi a lezione di taekwondoo. ...
Recentemente la comunità di Budrio e i suoi genitori sono stati sconvolti dal tentato adescamento subito da un bambino di 10 anni avvicinato in macchina da un uomo, mentre si recava da solo a piedi a lezione di taekwondoo. ... 
 Due ragazzine (12 anni? 14?) entrano in libreria a Budrio.
Scusa abbiamo un problema puoi aiutarci? Abbiamo trovato queste chiavi per terra lungo la strada della scuola, come possiamo fare per farle ritrovare al proprietario? Ci puoi dare un consiglio? ...
Due ragazzine (12 anni? 14?) entrano in libreria a Budrio.
Scusa abbiamo un problema puoi aiutarci? Abbiamo trovato queste chiavi per terra lungo la strada della scuola, come possiamo fare per farle ritrovare al proprietario? Ci puoi dare un consiglio? ... 
 Questa [foto, a lato] è la postazione nella piazza dove, più che in qualsiasi altro posto della città, si possono acquisire notizie di primissima mano. L’osservatorio è presidiato per diverse ore già di prima mattina con l’arrivo degli osservatori che dovranno prendere nota di quanto succede fino al rapporto che verrà fatto di lì, a quando si aggiungeranno al gruppo i commentatori....
Questa [foto, a lato] è la postazione nella piazza dove, più che in qualsiasi altro posto della città, si possono acquisire notizie di primissima mano. L’osservatorio è presidiato per diverse ore già di prima mattina con l’arrivo degli osservatori che dovranno prendere nota di quanto succede fino al rapporto che verrà fatto di lì, a quando si aggiungeranno al gruppo i commentatori....
 Forse non tutti hanno letto l’ordinanza emessa dal Sindaco il 12 Novembre scorso e riguardante la gestione della raccolta rifiuti e le sanzioni per i “comportamenti non conformi”...
Forse non tutti hanno letto l’ordinanza emessa dal Sindaco il 12 Novembre scorso e riguardante la gestione della raccolta rifiuti e le sanzioni per i “comportamenti non conformi”...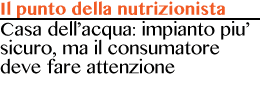
 Il nostro organismo è composto al 60% di acqua, e per mantenere una corretta idratazione è importante bere almeno 1,5 l di acqua al giorno. Ma quale acqua è meglio utilizzare, l’acqua minerale o l’acqua del rubinetto?
Il nostro organismo è composto al 60% di acqua, e per mantenere una corretta idratazione è importante bere almeno 1,5 l di acqua al giorno. Ma quale acqua è meglio utilizzare, l’acqua minerale o l’acqua del rubinetto?
Petra, è un vizio Italiano quello di denunciare il problema e pensare che il fato provveda alla soluzione.
Grazie per il bel resoconto.
Un articolo sopra la media di questo giornale. Complimenti.
Sentivamo la mancanza dei suoi commenti moralizzatori di sinistra, sig. Carnazzo. 😀
Abituato com’è a leggere ben altri giornali del tipo Repubblica, Corsera, L’Unità o Il Manifesto, è ovvio che consideri questo articolo sopra la media rispetto agli altri presenti su BudrioNext.
Sono onorato di essere addirittura ricordato per aver lasciato due-tre commenti in tutto.
Se la può interessare, leggo Budrio Next molto ma molto più spesso dei giornali che lei ha citato 🙂 .
Sì sì …. E io mi ritengo onorato della sua risposta (da ridere), sig. Carnazzo, al mio commento su questo articolo riguardante il tema della violenza sulle donne.
😀